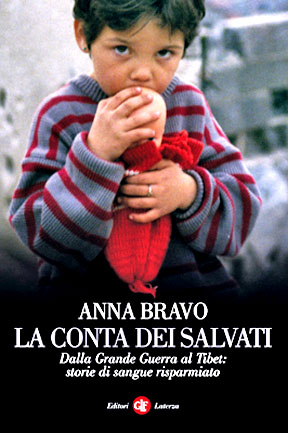 |
|
Fonte: la Stampa La nonviolenza non è fatta per le anime belle Una pratica sulla quale si addensano gli stereotipi. Forse si capisce meglio precisando ciò che non è e non fa. Si scrive molto di guerre, eccidi e violenze. È il racconto del sangue versato.Ma c’è anche chi ha lavorato per risparmiare il sangue. Come quei soldati della Grande guerra che concordavano tregue fra le trincee opposte. O quei danesi che nel loro Paese occupato dai nazisti misero in salvo i concittadini ebrei. O quegli italiani che, dopo l’8 settembre 1943, nascosero e protessero migliaia di militari sbandati e di prigionieri di guerra alleati. Senza dimenticare che non sempre le diplomazie e i governi tramano la guerra, in qualche caso possono anche tramare la pace. A queste e altre vicende è dedicato un libro della storica Anna Bravo in uscita per Laterza, titolo La conta dei salvati, sottotitolo Dalla Grande Guerra al Tibet: storie di sangue risparmiato. Anticipiamo qui uno stralcio dal primo capitolo, «Violenza, nonviolenza, storia». La nonviolenza ha una storia complessa, vari filoni, radici eterogenee, dal cristianesimo delle origini al buddismo, dall’induismo al pensiero mistico. Nella modernità ha una parentela con i socialisti detti utopisti, e capostipiti come Thoreau e Tolstoj. Non la si può identificare con il pacifismo, che ne è piuttosto un’espressione, e che a sua volta copre realtà diverse. Nell’Ottocento e nel primo Novecento ha lavorato per il disarmo e l’arbitrato internazionale. Durante la guerra fredda ha lottato contro la logica dei blocchi e il nucleare, anche se spesso inmodo sbilanciato (per esempio, no a nuove basi americane in Europa occidentale, silenzio o quasi su quelle sovietiche nell’Europa orientale). Piuttosto che un pacifista, il nonviolento è un «facitore di pace». Sembra semplice. Ma a dispetto dei chiarimenti teorici e dei database, sulla nonviolenza si addensano gli equivoci. Il primo è la sfiducia: non può durare, non può vincere; l’ultimo è la pretesa del «tutto e subito»: dove ha avuto successo (a questo punto l’esempio d’obbligo è il Sudafrica) non è riuscita a risolvere le questioni di fondo – come se ogni nuovo corso non si trovasse di fronte al medesimo problema. Fra scetticismo e aspettative palingenetiche, c’è una catena così fitta di stereotipi che forse la nonviolenza si capisce meglio precisando quello che non è e non fa. Non si limita a rigettare le armi proprie e improprie, sa rifiutare l’odio e cerca di trasmettere al nemico questo talento. Non rinuncia ai conflitti, li apre, ma prova a affrontarli in modo evoluto, con soluzioni in cui nessuno sia danneggiato, umiliato, battuto, soluzioni «winwin», come insegna la teoria dei giochi. Non vive negli interstizi lasciati liberi dal potere: lo sfida. Non dipende dalla sua benevolenza, lo costringe semmai a essere più benevolo.Molti pensano che Gandhi potesse agire perché il governo britannico glielo consentiva; certo la Gran Bretagna non è ilTerzo Reich,ma se approda a una certa tolleranza è perché il movimento non le lascia scelta fra il massacro e la trattativa. Non è solo una pratica politica: è un modello per le relazioni fra gruppi e fra singoli. Non è equidistante di fronte alle disparità sociali. Gandhi avversava il sistema delle caste, e se caldeggiava l’adozione di un unico tipo di abito per gli indiani, lo faceva sia per boicottare i tessuti inglesi sia per testimoniare l’uguaglianza di tutti. A Memphis, dove viene ucciso nel ’68, Martin Luther King era andato a sostenere la lotta degli spazzini per salari migliori e per i diritti sindacali, e a promuovere la Poor People Campaign. Non è un dogma: visto che qualsiasi attività umana comporta una sia pur minima distruzione di vita, l’obiettivo, constata Gandhi, è limitare quanto più possibile la violenza nel mondo; lo stesso principio del non uccidere prevede delle eccezioni se uccidere è l’unico modo di salvare gli indifesi da un pericolo mortale. Non è pavidità né remissività: richiede pazienza, mitezza, e coraggio davanti alla ferocia altrui – esiste una combattività nonviolenta molto temuta da chi è al potere. Non è spontaneismo ingenuo: inventa tattiche nuove. Non è una pratica per anime belle, capeggiata da esotici visionari, riservata a realtà con tasso minimo di tensioni interne. L’India era un paese gremito di contraddizioni, e Gandhi un leader sperimentato, abile nel negoziare e nell’organizzare grandi scene di teatro politico da esporre agli occhi del mondo. Quanto alla tipologia degli Stati, si dà vita a lotte nonviolente persino nell’Europa sotto dominio nazista. Non è un’esclusiva delle fedi religiose, anche se può trarne una forza straordinaria. Non è «cosa da donne», è universale, anzi ridefinisce i modelli di genere, valorizzando la compassione negli uomini, e nelle donne la fiducia in se stesse. Ma è vero che tra nonviolenza e femminismo c’è un’affinità: tutte e due riscrivono la storia, implicano una rivoluzione interiore, valorizzano le mediazioni, si richiamano alla pazienza, al senso del limite, alla sobrietà, alla cura delle cose piccole e gracili, che il prometeismo maschile-militartecnonologico si è diligentemente impegnato a distruggere. E per le donne i risultati più duraturi sono storicamente legati al tempo di pace, o quantomeno a forme di lotta poco militarizzate. Peccato che per anni nonviolenza e femminismo si siano frequentati poco. Il pensiero nonviolento non ha in genere riconosciuto nella disparità uomodonna la prima radice dell’oppressione. Il neofemminismo si è misurato con Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Lacan, gli strutturalisti, gli studi post-coloniali, molto meno con la nonviolenza. In compenso ha messo a fuoco la radice maschile dei meccanismi che ratificano la guerra, le sue leggi, i suoi simboli; e ha teorizzato la differenza tra il conflitto, una forma delle relazioni con l’Altro, e la guerra che lo vuole annientare.
|
|
|