| torna al sommario |
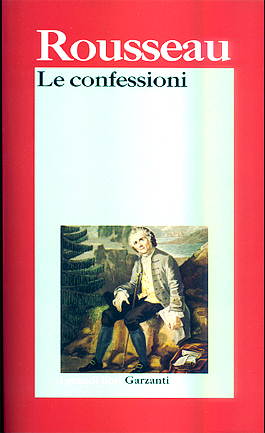 |
| tratto da www.tecalibri.it
Le confessioni di Jean Jacques Rousseau Garzanti 2006 LIBRO PRIMO Intus et in cute Mi inoltro in un'impresa senza precedenti, l'esecuzione della quale non troverà imitatori. Intendo mostrare ai miei simili un uomo in tutta la verità della sua natura; e quest'uomo sarò io. Io solo. Sento il mio cuore e conosco gli uomini. Non sono fatto come nessuno di quanti ho incontrati; oso credere di non essere fatto come nessuno di quanti esistono. Se pure non valgo di più, quanto meno sono diverso. Se la natura abbia fatto bene o male a spezzare lo stampo nel quale mi ha formato, si potrà giudicare soltanto dopo avermi letto. La tromba del giudizio finale suoni pure, quando vorrà: con questo libro fra le mani mi presenterò al giudice supremo. Dirò fermamente: «Qui è ciò che ho fatto, ciò che ho pensato, ciò che sono stato. Ho detto il bene e il male con identica franchezza. Nulla ho taciuto di cattivo e nulla ho aggiunto di buono, e se mi è occorso di usare, qua e là, qualche trascurabile ornamento, l'ho fatto esclusivamente per colmare i vuoti della mia debole memoria; ho potuto supporre vero quanto sapevo che avrebbe potuto esserlo, mai ciò che sapevo falso. Mi sono mostrato così come fui, spregevole e vile, quando lo sono stato, buono, generoso, sublime quando lo sono stato: ho disvelato il mio intimo così come tu stesso l'hai visto. Essere esterno, raduna intorno a me la folla innumerevole dei miei simili; ascoltino le mie confessioni, piangano sulle mie indegnità, arrossiscano delle mie miserie. Scopra ciascuno di essi a sua volta, con la stessa sincerità, il suo cuore ai piedi del tuo trono; e poi che uno solo osi dirti: «Io fui migliore di quell'uomo.» Pagina 64 Di religione avevo dunque tutto ciò che un ragazzo della mia età poteva avere. Ne avevo anche di più, e perché infatti mascherare qui il mio pensiero? La mia non fu un'infanzia da fanciullo; pensai, sentii sempre da uomo. Solo crescendo sono rientrato nella normalità; nascendo, ne ero uscito. Si riderà vedendo che mi presento modestamente come un prodigio. E sia: ma quando si sarà ben riso, lo si trovi un bambino che a sei anni i romanzi attraggono, interessano, trascinano al punto da piangerne a calde lacrime; allora sentirò ridicola la mia vanità, e mi convincerò d'aver torto. Così, quando ho detto che ai ragazzi non bisogna parlare affatto di religione, se si vuole che un giorno ne abbiano, e che essi sono incapaci di conoscere Dio, anche alla nostra maniera, ho tratto questo mio convincimento dalle mie indagini, non dalla mia personale esperienza: sapevo che essa non sarebbe servita a nulla, per gli altri. Trovate dei Jean-Jacques Rousseau a sei anni, e parlategli di Dio a sette, vi garantisco che non correte alcun rischio. Si sente, credo, che aver religione significa, per un ragazzo e persino per un uomo, seguire quella nella quale si è nati. Qualche volta se ne toglie; raramente se ne aggiunge; la fede dogmatica è un frutto dell'educazione. Oltre a questo principio comune che mi legava al culto dei miei padri, provavo l'avversione al cattolicesimo, particolare alla nostra città, il quale ci veniva presentato come un'orribile idolatria, e il cui clero ci veniva dipinto con le più fosche tinte. Quel sentimento si era in me così radicato che, da principio, non intravvedevo mai interno di chiesa, non incontravo mai prete in cotta, non udivo mai campanello di processione, senza un fremito di terrore e di angoscia, che nelle città mi lasciò ben presto, ma che sovente mi ha ripreso nelle parrocchie di campagna, più somiglianti a quelle dove l'avevo inizialmente provato. Invero, questa impressione era in singolare contrasto con il ricordo delle carezze che i curati dei dintorni di Ginevra elargiscono volentieri ai ragazzi di città. Mentre la campanella del viatico mi metteva paura, la campana della messa o del vespro mi ricordava una colazione, una merenda, del fresco burro, dei frutti, dei latticini. Anche il buon pranzo del signor di Pontverre aveva prodotto un grande effetto. Così, facilmente m'ero illuso, su tutto ciò. Guardando il papismo solo attraverso i suoi legami con svaghi e ghiottonerie, mi ero assuefatto facilmente all'idea di viverci; ma quella di farvi un'entrata solenne mi si era presentata solo di sfuggita, e in un avvenire remoto. In quel momento non vi fu più spazio per gli equivoci: con il più vivo orrore vidi quale specie di impegno avevo assunto e la sua conseguenza inevitabile. I futuri neofiti che mi circondavano non erano i più adatti a sostenere il mio coraggio col loro esempio, e non riuscii a dissimularmi che la santa opera cui mi accingevo altro in fondo non era che un atto da bandito. Benché giovane ancora, sentii come, quale che fosse la vera religione, stavo per vendere la mia, e che, quand'anche avessi scelto bene, in fondo al mio cuore mi preparavo a mentire allo Spirito Santo, e meritarmi il disprezzo degli uomini. Più ci pensavo, più mi indignavo contro me stesso; e gemevo della sorte che mi aveva condotto là, come se quella sorte non fosse opera mia. Vi furono momenti in cui quelle riflessioni divennero così intense, che se avessi per un istante trovato la porta aperta, sarei sicuramente evaso; ma non mi fu possibile, e la risoluzione non resse con molta fermezza. Troppi segreti desideri la combattevano per non sopraffarla. D'altronde, l'ostinazione nel proposito di non tornare a Ginevra, la vergogna, la difficoltà stessa di rivarcare i monti, e l'imbarazzo di vedermi lontano dal mio paese, senza amici, senza risorse; tutto contribuiva a farmi considerare i miei rimorsi di coscienza come un pentimento tardivo. Fingevo di rimproverarmi il già fatto, per scusare quanto mi accingevo a fare. Aggravando i torti del passato, guardavo l'avvenire come una conseguenza necessaria. Non mi dicevo: «Nulla è ancora avvenuto, puoi restare innocente se vuoi,» mi dicevo: «Piangi sul delitto di cui ti sei reso colpevole, e che ti sei messo nella necessità di portare a compimento.» Quale rara forza d'animo mi sarebbe infatti occorsa, a quell'età, per revocare quanto fin lì avevo potuto promettere o lasciato sperare, per spezzare le catene che mi ero date, per dichiarare intrepidamente che intendevo restare fedele alla religione dei miei padri, a rischio di tutto quanto poteva conseguirne! Questo vigore non si addiceva alla mia età, ed era improbabile che ottenesse un buon esito. Le cose si erano spinte troppo oltre perché se ne accettasse una smentita; e più la mia resistenza fosse stata grande più, in un modo o nell'altro, si sarebbero fatti un dovere di sopraffarla. Il sofisma che mi perdette fu quello della maggior parte degli uomini, che si lamentano di mancare di forza quando è già troppo tardi per farne uso. La virtù può costarci cara solo per colpa nostra, e se risolvessimo d'essere sempre saggi raramente avremmo bisogno d'essere virtuosi. Ma inclinazioni facili a superare ci trascinano senza resistenza; cediamo a tentazioni futili di cui sprezziamo il pericolo. Senza avvedercene, scivoliamo in situazioni pericolose, che facilmente potevamo scongiurare, ma alle quali non possiamo più sottrarci senza eroici sforzi che ci spaventano, e precipitiamo infine nell'abisso chiedendo a Dio: «Perché mi hai fatto così debole?» Ma, nostro malgrado, egli risponde alle nostre coscienze: «Ti ho fatto troppo debole per risalire dal baratro perché ti ho fatto forte quanto bastava a non cadervi.» Non presi precisamente la risoluzione di farmi cattolico; ma, vedendo il termine ancora lontano, presi tempo per assuefarmi a quell'idea, e nell'attesa immaginavo qualche avvenimento imprevisto che mi potesse trarre d'impaccio. Decisi, per guadagnare tempo, di opporre la più bella difesa possibile. In breve la mia vanità mi dispensò dal pensare alla mia risoluzione, e come mi accorsi che a volte mettevo in imbarazzo i miei istruttori, non mi ci volle di più per tentare di annientarli. Misi in quell'impresa uno zelo persino ridicolo: mentre essi lavoravano me, pretendevo di lavorare loro. Credevo ingenuamente che bastasse convincerli per impegnarli a farsi protestanti. Non trovarono dunque in me tutta la malleabilità che si aspettavano, né dal lato dei lumi né da quello del volere. In generale i protestanti sono meglio istruiti dei cattolici; né può essere altrimenti: la dottrina dei primi esige la discussione, l'altra la sottomissione. Il cattolico deve accettare la decisione che gli si detta; il protestante deve imparare a decidere. Questo era scontato; ma né dal mio stato né dalla mia età s'aspettavano difficoltà preoccupanti per persone esercitate. Non avevo d'altronde ancora fatto la mia prima comunione, né ricevuto la dottrina che la concerne: sapevano anche questo, ma non sapevano che ero stato, in compenso, ben istruito in casa del signor Lambercier, e che disponevo per di più d'un piccolo bagaglio, nella Storia della Chiesa e dell'impero, scomodissimo per quei signori, imparato quasi a memoria con mio padre e poi quasi dimenticato, ma che riaffiorò alla mia mente a mano a mano che la disputa si inaspriva. Un vecchio prete, piccolo ma abbastanza venerabile, ci tenne in comune la prima conferenza. Per i miei compagni era più un catechismo che un dibattito, e il prete era impegnato più a istruirli che a risolvere i loro dubbi. Non fu lo stesso per me. Quando venne il mio turno, lo bloccai su tutto, non gli risparmiai una sola delle difficoltà che potevo sollevargli, il che rese la conferenza molto lunga e noiosissima per i presenti. Il vecchio prete parlava molto, si scaldava, menava il can per l'aia e si cavava d'impaccio asserendo di non capir bene il francese. Il giorno dopo, per paura che le mie indiscrete obiezioni scandalizzassero i miei compagni, mi misero in una stanza a parte con un altro prete, più giovane, buon parlatore, vale a dire costruttore di lunghe frasi, e contento di sé semmai dottore lo fu. Non mi lasciai soggiogare eccessivamente dal suo aspetto maestoso, tuttavia, ma sentendo che dopo tutto facevo il mio dovere, cominciai a rispondergli con sufficiente sicurezza e a punzecchiarlo qua e là come meglio potevo. Credeva di sopraffarmi con sant'Agostino e san Gregorio e gli altri padri, e s'accorgeva, con stupore incredibile, che maneggiavo quei padri quasi con la stessa sua destrezza: non che li avessi mai letti, e forse nemmeno lui, ma ne avevo ritenuto a mente molti brani tratti dal mio Le Sueur; e appena me ne citava uno, senza discutere la sua citazione, gli replicavo con un'altra dello stesso padre, e che spesso lo cacciava nei guai. Lui aveva la meglio, alla fine, per due ragioni: una, che era il più forte, e che, sentendomi per così dire alla sua mercé, capivo benissimo, per giovane che fossi, che non bisognava passare il segno; mi rendevo conto, infatti, che il vecchio prete non aveva preso in simpatia né la mia erudizione né me; l'altra ragione era che il giovane era colto, e io no. Di conseguenza usava nel suo argomentare un metodo che io non potevo seguire, e come si sentiva incalzato da un'obiezione imprevista, la rimandava al giorno dopo, dicendo che mi allontanavo dal tema presente. A volte respingeva anche tutte le mie citazioni, sostenendo che erano false e, offrendosi d'andare a cercarmi il libro, mi sfidava a reperirvele. Sentiva di non rischiare gran cosa, e che con tutta la mia erudizione d'accatto, ero poco addestrato a maneggiare i libri e troppo poco latinista per rintracciare un brano in un grosso torno, anche quando fossi stato sicuro che vi fosse. Lo sospetto persino d'aver usato la slealtà di cui accusava i ministri protestanti, e di avere a volte inventato le citazioni per aggirare un'obiezione che lo metteva in difficoltà. Mentre queste piccole soperchierie si ripetevano e i giorni trascorrevano in dispute, in borbottii di preghiere e nel farmi furbo, mi capitò una brutta avventuretta piuttosto disgustosa e che per poco non finì malissimo per me. Pagina 244 Di solito facevamo colazione con caffellatte. Era il momento della giornata in cui eravamo più tranquilli, e si conversava più a nostro agio. Quelle sedute, usualmente lunghe, mi hanno lasciato un vivo gusto per le colazioni, e preferisco infinitamente l'uso dell'Inghilterra o della Svizzera, dove la colazione è un pasto vero e proprio che riunisce tutti, a quello della Francia, dove ciascuno fa colazione da solo nella propria stanza, o più sovente la salta del tutto. Dopo un'ora o due di conversari, andavo ai miei libri fino all'ora di pranzo. Cominciavo con qualche libro di filosofia, come la Logica di Port-Royal, il Saggio di Locke, Malebranche, Leibnitz, Descartes, ecc. Scoprii ben presto che tutti quegli autori erano fra loro in contraddizione pressocché perpetua, e formulai il progetto chimerico di metterli d'accordo, che mi costò molta fatica e mi fece perdere molto tempo. La testa mi si confondeva e non avanzavo di un passo. Infine, rinunciando anche a questo metodo, ne adottai uno infinitamente più efficace, e al quale attribuisco tutti i progressi che posso aver fatto, nonostante il mio difetto di capacità; poiché è certo che ne ebbi sempre pochissima per lo studio. Leggendo ciascun autore, mi imposi la norma di adottare e seguire tutte le sue idee senza intromettervi le mie né quelle di un altro, e senza mai polemizzare con lui. Mi dissi: «Cominciamo col farci una scorta di idee, vere o false, ma chiare, in attesa che la mia testa ne sia abbastanza fornita da poterle confrontare e scegliere.» Il metodo non è privo di inconvenienti, lo so, ma è servito allo scopo di istruirmi. Dopo alcuni anni trascorsi a non pensare esattamente che secondo sistemi altrui, mi sono trovato a disposizione, senza riflettere, per così dire, e quasi senza ragionare, un fondo di cognizioni abbastanza vasto da rendermi autonomo e in grado di pensare senza il soccorso altrui. Allora, quando viaggi ed affari mi hanno sottratto i mezzi di consultare i libri, mi sono divertito a ripensare e comparare quanto avevo letto, a pesare ogni cosa alla bilancia della ragione, e talvolta a giudicare i miei maestri. Pur avendo iniziato tardi a esercitare la mia facoltà di giudizio, non m'è parso che avesse perduto il suo vigore; e quando pubblicai le mie proprie idee, non mi si è accusato di essere un servile discepolo e di giurare in verba magistri. Di là passavo alla geometria elementare, giacché non sono mai andato oltre, ostinandomi nel voler vincere la mia scarsa memoria a forza di tornare cento volte sui miei passi e di ricominciare senza posa il cammino. Non apprezzai quella di Euclide, che cerca il concatenarsi delle dimostrazioni piuttosto che il connettersi dei concetti; preferii la geometria di padre Lami, che divenne da allora uno dei miei autori favoriti, e le cui opere rileggo ancora con piacere. Poi veniva l'algebra, e sempre padre Lami scelsi come guida. Quando fui abbastanza avanti, usai la Scienza del calcolo del padre Reyneau, quindi la sua Analisi dimostrata, che sfiorai soltanto. Non sono mai andato tanto oltre da intender bene l'applicazione dell'algebra alla geometria. Non mi piaceva affatto questo modo di procedere senza vedere ciò che si fa, e mi sembrava che risolvere un problema di geometria con le equazioni fosse come suonare un motivo girando una manovella. La prima volta che trovai mediante il calcolo che il quadrato di un binomio è composto dal quadrato di ciascuna delle sue parti e del doppio prodotto dell'una per l'altra, malgrado l'esattezza della mia moltiplicazione non volli credere a niente finché non ebbi eseguita la figura. Non che mi mancasse un gusto spiccato per l'algebra, non considerandone che la quantità astratta; ma applicata alla spazialità volevo vedere l'operazione tradotta in linee, altrimenti non ci capivo più nulla. E dopo l'algebra, veniva il latino. Era il più penoso dei miei studi, dove mai feci grandi passi avanti. Mi attenni dapprima al metodo latino di Port-Royal, ma senza frutto. Quei versi ostrogoti mi facevano star male, e non riuscivano a entrarmi nell'orecchio. Mi smarrivo in quella foresta di regole, e come imparavo l'ultima dimenticavo tutte le precedenti. Uno studio di parole non è il più adatto a un uomo privo di memoria, e proprio per obbligare la mia memoria ad acquistare capacità mi ostinavo in quello studio. Dovetti infine abbandonarlo. Afferravo abbastanza la costruzione per riuscire a leggere un autore facile, con l'aiuto del dizionario. Seguii questa via e mi trovai bene. Mi applicai alla traduzione, non per iscritto, ma a mente, e mi limitai a questa. A forza di tempo e di esercizio, sono arrivato a leggere abbastanza correntemente gli scrittori latini, mai però a parlare né a scrivere in quella lingua; cosa che mi ha messo sovente in difficoltà, quando mi trovai, non so come, arruolato fra i letterati. Pagina 325 La musica in Italia costa così poco che non vale la pena di privarsene quando se ne ha la passione. Noleggiai un clavicembalo, e per un misero scudo avevo in casa mia quattro o cinque concertisti, con i quali una volta la settimana mi esercitavo ad eseguire i brani che più m'erano piaciuti all'Opéra. Feci provare anche alcune sinfonie delle mie Muse galanti. Sia che piacessero realmente, o che mi volessero adulare, il maestro dei balletti di San Giovanni Crisostomo me ne fece richiedere due, che ebbi il piacere di ascoltare nell'esecuzione di quella mirabile orchestra, e che vennero danzate da una piccola Bettina, graziosa e soprattutto amabile fanciulla, mantenuta da uno spagnolo amico nostro chiamato Fagoaga, e in casa della quale andammo spesso a passare la sera. Ma, a proposito di ragazze, non è certo in una città come Venezia che se ne fa astinenza: non avete niente, mi si potrebbe chiedere, da confessare a questo riguardo? Sì, ho qualcosa da dire in effetti, e mi accingo alla confessione con la stessa innocenza dimostrata in ogni altra. Ho sempre provato un certo disgusto per le donne pubbliche, e a Venezia non avevo altro sotto mano, giacché l'accesso alla maggior parte delle case della città m'era precluso per via del mio impiego. Le figlie del signor Le Blond erano amabilissime, ma difficili da avvicinare, e stimavo troppo il padre e la madre per sognarmi soltanto di desiderarle. Avrei avuto maggior inclinazione per una giovane signorina di Cataneo, figlia dell'agente del re di Prussia: ma Carrio ne era innamorato, e si parlava persino di matrimonio. Egli era agiato, io non possedevo nulla; lui aveva uno stipendio di cento luigi, io di cento pistole; e a parte che non intendevo rivaleggiare con un amico, sapevo come ovunque, e a Venezia specialmente, con una borsa così sguarnita non si può mettersi a fare il galante. Non avevo perduto la funesta abitudine di ingannare i miei bisogni; troppo occupato per avvertire vivamente quelli che il clima accende, vissi circa un anno in quella città savio com'ero stato a Parigi, e ne sono ripartito dopo diciotto mesi senza essermi accostato a donne che due sole volte, nelle singolari circostanze che sto per narrare. La prima me la procurò l'onesto gentiluomo Vitali, qualche tempo dopo le pubbliche scuse che l'obbligai a chiedermi in forma ufficiale. Si parlava a tavola dei divertimenti di Venezia. Quei signori mi rimproveravano la mia indifferenza per il più pepato di tutti, vantando la gentilezza delle cortigiane di Venezia, e dicendo che non ve n'erano di eguali al mondo. Domenico disse che dovevo conoscere la più amabile; che voleva condurmi da lei e che ne sarei rimasto contento. Mi misi a ridere di questa premurosa offerta; e il conte Piati, uomo già vecchio e venerabile, disse, con una franchezza che da un italiano non mi sarei aspettata, che mi reputava troppo accorto per lasciarmi condurre, dal mio nemico, presso donne di malaffare. Non ne avevo infatti né l'intenzione né la tentazione, e tuttavia, per una di quelle incoerenze che stento io stesso a capire, finii per lasciarmi irretire, contro la mia inclinazione, il mio cuore, la mia ragione, la mia stessa volontà, unicamente per debolezza, per vergogna di mostrare diffidenza, e, come si dice in quel paese, «per non parer troppo coglione». La «Padoana», dalla quale ci recammo, era d'aspetto graziosissimo, persino bella, ma non d'una bellezza di mio gusto. Domenico mi lasciò con lei; feci portare dei sorbetti, la feci cantare, e dopo una mezz'ora volli andarmene, lasciando sulla tavola un ducato; ma costei ebbe il singolare scrupolo di volerselo guadagnare a tutti i costi, ed io la singolare dabbenaggine di toglierle lo scrupolo. Tornai al palazzo talmente persuaso di essermi buscato una pepata, che, per prima cosa mandai a chiamare il chirurgo per chiedergli qualche tisana. Nulla può eguagliare l'angoscia che mi dominò per tre settimane, senza che nessun malessere reale, alcun sintomo concreto la giustificasse. Non potevo concepire che si potesse uscire incolumi dalle braccia della Padoana. Lo stesso chirurgo dovette farsi in quattro per rassicurarmi. Ci riuscì solo convincendomi che ero conformato in modo particolare talché non potevo facilmente contrarre contagi, e sebbene mi sia esposto forse meno d'ogni altro a questa esperienza, il fatto che la mia salute non abbia mai subito infortuni da questo lato, mi conferma che il chirurgo aveva ragione. Questa persuasione tuttavia non mi ha mai reso temerario, e, se davvero godo di quel privilegio naturale, posso dire di non averne abusato. L'altra mia avventura, quantunque anch'essa con una prostituta, fu tutt'affatto diversa, sia per la sua origine che per i suoi effetti.
|
| top |